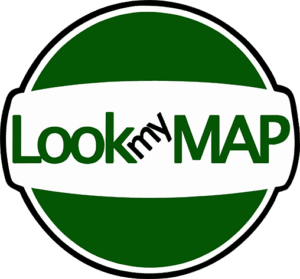Descrizione
Per secoli i Milanesi hanno considerato il Castello emblema di tirannide e dominio straniero. Più volte, in una lunga storia, i cittadini hanno tentato di attaccare e demolire l’odiato edificio. Solamente con l’Unità d’Italia, trasformandosi in un centro di cultura, il Castello è diventato caro ai Milanesi e simbolo della città.
Galeazzo II Visconti, divenuto Signore della zona occidentale di Milano, costruisce, tra il 1360 e il 1370, una rocca a cavallo della cinta medievale, inglobando la pusterla di Porta Giovia o Zobia. Il successore Gian Galeazzo aggiunge alla costruzione, nel 1392, edifici per gli alloggiamenti delle truppe stipendiate. Le due parti della struttura sono separate dal fossato della cinta medievale, il cosiddetto fossato morto, e verranno collegate solo successivamente da Filippo Maria, l'ultimo dei Visconti. È proprio in questo periodo che il Castello, il più grande tra quelli edificati dai Visconti, di pianta quadrata di circa 180 metri di lato, munito di quattro torri anch’esse quadrate e di un ampio recinto, diventa residenza; i campi incolti sul lato nord-ovest si trasformano in un “zardinum” o “barcho”.
Dopo contrastanti opinioni su cosa fare del Castello, tra le quali si ricorda il progetto di Angelo Colla (1882-1884) che proponeva di trasformarlo in una struttura goticheggiante, si decide di salvare l’antico edificio.
L’intera cittadinanza di Milano partecipa alla sottoscrizione pubblica per riportare il complesso all’antico splendore. Sono anni di intenso lavoro, durante i quali si cancellano le strutture non appartenenti alla fabbrica originaria e si indagano le tracce antiche. Riaffiorano finestre in cotto e significative tracce di pitture sforzesche. Si riscoprono le decorazioni dipinte nella Sala delle Asse e nella Sala del Tesoro. Tornano gradatamente in luce gli ori della Cappella Ducale. La Rocchetta e la Corte Ducale vengono ripristinate nelle forme originarie e destinate a ospitare musei e istituti culturali.
L’impegno di Luca Beltrami trova la massima espressione nella ricostruzione della facciata del Castello verso la città e soprattutto della Torre del Filarete, le cui forme l’architetto ricostruisce servendosi di un dipinto di scuola leonardesca (la Madonna Lia) e di un graffito rinvenuto nella cascina Pozzobonelli. Anche le torri dei castelli di Vigevano e Cusago sono prese a modello per quella che è una ricostruzione totale ma filologicamente, almeno secondo le concezioni dell’epoca, corretta. Prima di procedere alla ricostruzione, l’architetto produce, nel 1895, un modello in legno di dimensioni reali. La torre ricostruita, dedicata a re Umberto I, viene solennemente inaugurata il 24 settembre 1905.
Si apre per il Castello Sforzesco un nuovo capitolo.
Eccezionale testimonianza della presenza di Leonardo da Vinci (1452-1519) alla corte sforzesca, la Sala delle Asse è l’ambiente più illustre del Castello. Collocata al piano terra della torre angolare posta a nord-est, la Falconiera, la sala deve il suo nome al rivestimento ligneo che in età sforzesca si utilizzava per rendere alcuni ambienti meno freddi e più confortevoli. Ornata di affreschi a motivi araldici per Galeazzo Maria Sforza, la sala ha ricevuto sotto Ludovico il Moro la celebre decorazione leonardesca, nel 1498. Se alcune missive tra il Moro e il grande artista permettevano di conoscere l’esistenza di una decorazione di Leonardo.
Al centro delle celebrazioni leonardesche in Castello recentemente concluse, la sala ha attirato 350.000 visitatori.
Ultima opera, non finita, di Michelangelo Buonarroti (1475-1564), la Pietà Rondanini è testamento e meditazione del vecchio artista sulla morte e la salvezza dell’anima. In quest’opera lo scultore rinuncia alla perfezione del corpo e alla sua eroica bellezza, trasformando il Cristo morto in emblema di sofferenza. La posizione dei corpi di Maria e Gesù ad altezze diverse sembra suggerire l’intrecciarsi di più momenti della vicenda di Cristo: deposizione dalla Croce, seppellimento, addirittura Resurrezione, nel dissolvimento del corpo del Figlio nell’abbraccio materno. Lasciata incompiuta per la morte di Michelangelo, la Pietà è testimonianza degli ultimi anni del genio.
Dal 2 maggio 2015 si può vedere la Pietà nel nuovo museo, allestito nell'antico Ospedale Spagnolo nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.
Categoria
Città
Chiuso
-
Lunedi
Chiuso
-
Martedì
9:30 am - 5:30 pm
-
Mercoledì
9:30 am - 5:30 pm
-
Giovedì
9:30 am - 5:30 pm
-
Venerdì
9:30 am - 5:30 pm
-
Sabato
9:30 am - 5:30 pm
-
Domenica
9:30 am - 5:30 pm
Novembre 30, 2025 10:58 pm local time